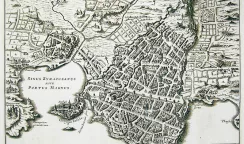Dopo la lunga marginalità politica ed economica vissuta sin dalla conquista araba l’attiva partecipazione dei siracusani ai fatti del Vespro rappresentò un importante punto di svolta che consenti alla città di rientrare a pieno titolo nello scenario politico isolano
Nell’agosto 1282 i siracusani furono infatti in grado di inviare in soccorso di Messina, stretta d’assedio da Carlo d’Angiò, propri uomini e cavalli, per i quali furono poi ricompensati con l’esenzione dal pagamento dei diritti di dogana in quel distretto.
Ciò sembra dimostrare non solo che la città si era ormai definitivamente risollevata dalla condizione in cui era ricaduta ma anche che, al suo interno, era attiva una solida classe dirigente.
Ma chi erano questi “notabili” siracusani che parteciparono attivamente alla rivolta del Vespro ? L’unico che ne parla è Filadelfo Mugnos (uno storico però notoriamente poco attendibile) secondo cui l’insurrezione fu capitanata da Perrello Mohac e Pietro Manuele.
Sempre secondo il Mugnos, dopo la rivolta la città “elesse a governatori: Luigi Callari, Calcerano Salvaggi, Luca Mariscalco, e a rettori: Leandro Molocca, Galatino Oliva, Perrello di Modica, Henrico Manuello, Corrado d’Arizzi, e Guglielmo Pedilepori”.
In realtà sull’argomento ne sappiamo davvero molto poco e anche i registri della cancelleria aragonese, seppur forniscono qualche nome, non aiutano più di tanto a dipanare il mistero.
Sappiamo infatti che Pietro il Grande che, già poco dopo la sua acclamazione a re di Sicilia aveva chiesto alla città di eleggere “i soliti ufficiali”, nell’ottobre del 1282 confermò l’elezione dei giudici Errico di Roffino, Niccolò Morena e Rainaldo d’Aversa e degli acatapani Markisio de Apollis e Filippo di Gervasio.
Successivamente, dovendo convocare per il 5 Novembre un generale colloquio a Catania, invitò le città siciliane a mandarvi quattro rappresentanti “o se lo desiderano anche più, scelti fra i migliori, i mediocri e i popolani, per trattarvi degli affari della guerra, dello stato dell’isola e della distruzione dei nemici”.
Siracusa scelse di inviare come suoi “ambasciatori”: Pietro di Maestro Oddone, Russo Milocca, Giacomo Merle, Guglielmo Fundico e Matteo de Oliva. Nel novembre dello stesso anno il re concesse poi a Markisio Merenda, dopo esser stato “debitamente esaminato”, il notariato di Siracusa.
Nel gennaio del 1283 ordinando agli ufficiali della città di mandare per le necessità belliche del regno arcieri e fanti, il re chiamava al servizio militare anche gli “equites” siracusani.
Da un elenco giunto fino a noi sappiamo che questi erano 37 appartenenti a 27 famiglie: De Capitano, Catalano, da Melilli, Antelino, Aurubella, Camera, Fundico, Gucia, Iacona, Luchasio, Maleta, Millotenx, Orlando, Symia, La Rocca, Lombardo, de Magistro Rogerio, Margulisio, Milocca, Murina, Novella, Oliva, Pandolfo, Punceto, Rubino e Traversa.
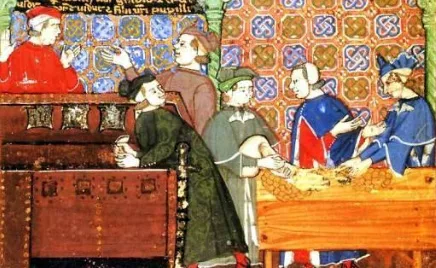
Queste in sostanza le uniche notizie di cui disponiamo sugli esponenti della classe dirigente cittadina negli anni a cavallo tra il Vespro e i primi anni della conquista aragonese.
Notizie che per quanto lacunose consentono di delineare i tratti di un notabilato ancora in via di formazione e che doveva comprendere indistintamente sia esponenti di condizione feudale sia elementi del ceto mercantile e burocratico della città. Non tutti gli “equites” siracusani convocati da re Pietro erano infatti esponenti del ceto feudale ma probabilmente appartenevano a quella vasta e indefinita categoria di detentori di beni immobili o rendite, oggetto di tassazione.
Tra i cavalieri che in qualità di sindaci parteciparono al parlamento di Catania detenevano beni feudali Matteo Oliva, in possesso di Solarino in territorio di Siracusa e Russo Milocca la cui famiglia doveva già possedere il feudo omonimo in territorio di Siracusa e quello di Arcimusa a Lentini.
Dubbia l’appartenenza al ceto feudale di Guglielmo Fundico e Giacomo Merle (Margulisio) mentre non si trova riscontro alcuno di Pietro di Maestro Oddone. Tra gli ufficiali eletti dalla città risulta citato tra gli equites il solo Niccolò Murena, non vi è traccia invece degli altri giudici ed acatapani, così come non sono presenti esponenti delle loro famiglie.
Anche Corrado de Camera era un feudatario anzi è l’unico cavaliere di cui conosciamo con certezza i possedimenti detenendo a quel tempo, “sub certa forma e sotto militare servizio”, i feudi Xiridia (Floridia) e Monastero. Ruggiero di Siracusa, indicato come Magistro Rogerio nell’elenco degli equites, risulta invece un importante esponente del ceto burocratico del regno dato che, l’11 Gennaio 1283, è attestato nel ruolo di secreto “al di qua del Salso”.
L’elevazione alla dignità cavalleresca di centinaia di nuovi esponenti, disposta nel giorno dell’incoronazione di Giacomo II, nel 1285, e di Federico III, nel 1296, amplierà considerevolmente il novero dei componenti del ceto nobiliare dell’isola, consentendo la partecipazione anche di alcuni elementi scelti fra i “borghesi” delle città e delle terre abitate siciliane.
A Siracusa oltre ad essere confermati alcuni elementi delle famiglie di antico retaggio normanno-svevo come i Mohac, che riottennero il possesso di Sortino, acquisirono feudi anche i catalani Ramon Marquet che ottenne i casali Margolli, Favarocta, Rachadeti e Gemelli e Garcia Pomar che, oltre ad esser stato nominato castellano di Siracusa, ottenne il feudo di Cassibile.
Il navarrese Gilio Assyn acquisì invece i feudi di Floridia e Monasteri che erano già appartenuti al defunto Corrado de Camera, mentre il notaio siracusano Giovanni Marrasio ottenne il feudo Carancino.
Alla fine del XIII secolo oltre che tra i feudatari il processo di ampliamento del ceto dirigente riguardò anche le famiglie che potevano concorre alle cariche elettive e partecipavano attivamente alla gestione delle gabelle locali.
Durante il regno di Federico III ai Ruffino, ai Merle ed ai Murena, già presenti tra gli ufficiali cittadini negli anni immediatamente successivi al vespro, si aggiunsero con ruoli sempre più importanti esponenti delle famiglie Arezzo, Selvaggio, Mancino, e Campisano.
© E' VIETATA LA RIPRODUZIONE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI